“L’Età fanciulla” di Armando Faraone
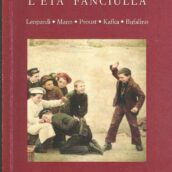
Scrittore interessante, curioso, questo Armando Faraone, che fa pensare a quella noblissima “casta” di intellettuali siciliani (a prescindere che poi scrivano o no) silenziosi e apparentemente lontani, che dagli scrigni delle loro limitate dimore spaziano per tutte le direzioni sulle ali di una fantasia culturale sciolta in una sorta di divertimento creativo.
Altrimenti non avrebbe potuto scrivere “L’età fanciulla”. L’ho letto e mi sono trovato a ripensare a quegli scrittori che spuntano all’improviso e scuotno la nostra provincia addormentata con l’urto della propria passione (sfrenata vorrei dire) per le lettere, pronta a concretizzarsi in pagine fonti di vero godimento.
Penso a Lucio Piccolo, a Tomasi di Lampedusa, allo stesso Bufalino, personaggi “altri” rispetto a quelli della quotidianità, anche letteraria, con cui ci misuriamo almeno per sopravvivere. Con costoro il rapporto è diverso ed a questa diversità ricondurrei il Faraone rimasto a vivere nel suo paese (come han fatto quelli succitati) , facendone il palcoscenico di una rappresentazione senza quinte, intensa e raffinata.
Di queste epifanie la Sicilia è capace, grazie a questi “rabdomanti” esploratori di sotterranei esistenziali da recuperare, che mentre credono di parlare degli altri parlano, piuttoso, di sé stessi.
Melo Freni
SU RICHIESTA DEL DIRETTORE, ABBIAMO AVUTO DALL’AUTORE L’INTRODUZIONE :
Scrivere su autori divenuti classici potrebbe risultare operazione improponibile, qualora se ne volesse accreditare una nuova lettura critica; pienamente giustificata, mi sembra di poter dire, se, invece, come si prefiggono i saggi contenuti in questa raccolta, ci si sofferma a chiarire i termini del rapporto arte-vita e, da questa finestra aperta sul mondo poetico di Leopardi, Proust, Thomas Mann, Kafka, Bufalino, cogliere affinità e differenze su una problematica riguardante le ragioni stesse dell’attività dello scrittore, che sebbene avvertita con particolare pregnanza dal Decadentismo, ha, in effetti, costituito un campo di impegno teorico su cui si è cimentata la modernità e il periodo solitamente definito del postmoderno, come a dire tutto il Novecento.
Questo mai spento interesse per l’attività letteraria e per la forma artistica in generale ha fatto si che sulla riflessione estetica e la funzione dell’arte si sia andato addensando il destino stesso della cultura europea, travagliata da un processo di transizione dal vecchio al nuovo, che ha visto, accanto alla sopravvivenza di forme tradizionali, l’esplosione di proclami di rinnovamento ab imis, che, quando non sono stati motivati da una sincera ricerca, si sono esauriti in velleitarie, quanto vacue esercitazioni formali. L’arte è diventata così non solo il campo di sperimentazione di nuove forme estetiche, particolarmente dal nouveau roman al pullulare delle avanguardie, ma il terreno sul quale si è tentato di acclarare un nuovo umanesimo. Un cammino ancora in corso, iniziato da quando i paradigmi tradizionali non sono apparsi adeguati ad esprimere la mutata sensibilità dell’uomo contemporaneo.
L’arte, come forma dell’attività spirituale, ha sempre mirato a ricondurre la precarietà dell’esistenza all’assoluto, a elevare in un cosmo ordinato e armonico il caos e il mistero che avvolgono la vita: “Ogni forma d’arte – scriveva il giovane Lukács – è definita dalla dissonanza metafisica della vita, che ha il compito di confermare e configurare l’arte come fondamento di una totalità in sé compiuta”. Il Romanticismo è stato il più grande tentativo di realizzare il sogno di fondere arte e vita, l’uno e il tutto, finito ed infinito, sul sostrato dell’idealismo che in Hegel aveva creduto di ricondurre la molteplicità contraddittoria della realtà empirica sotto l’idea della totalità. Sul presunto tramonto dell’oggettivismo antico, l’idealismo si era illuso di edificare, puntando sul ruolo fondativo del soggetto, una nuova dimensione dell’assoluto, che costituiva, pur sul fragile fondamento dell’io, un principio catalizzatore delle attività spirituali. Nell’esaltante euforia dei romantici, però, la vita, svaniva nelle sfumate atmosfere dell’indefinito e delle vaghe aspirazioni, non per nulla, la musica veniva considerata da Wackenroder, da Schopenhauer e dallo stesso Leopardi, la forma d’arte per eccellenza.
La reazione all’hegelismo, di Kierkegaard da una parte e di Feuerbach dall’altra, che esprimeva l’esigenza di riscattare l’esistenza individuale dall’universalismo del sistema, portava allo scoperto la fragilità dell’idealismo romantico, per cui l’esistenza, privata del fondamento assoluto, appariva in tutta la sua fragilità, che la problematica scelta religiosa del filosofo danese finiva per esaltare più che superare: problematicità della vita, quindi, e, di riflesso, problematicità dell’arte, che, persa la referenza ad una meta ideale, cercava le ragioni della sua funzione nell’esplorazione delle condizioni sociali in cui l’individuo conduce la propria vita. Alla rappresentazione dei temi sociali, si contrapponeva la poetica dei simbolisti volta a privilegiare l’autonomia formale dell’arte in una ricerca sottile di assonanze e analogie fino all’aspirazione di ridurre con Verlaine e soprattutto con Mallarmé le parole in musica. Con il simbolismo si dilatava la scissione tra arte e vita.
Gli scrittori e i poeti del Decadentismo vivranno con particolare intensità tale dicotomia, senza arrivare ad armonizzare il dualismo, dal momento che rimasero in una situazione oscillante tra la svalutazione dell’arte e la priorità del valore della vita e, per converso, tra l’esaltazione della bellezza artistica e il rifiuto della concreta realtà dell’esistenza. Una dialettica che, non confinabile al periodo del Decadentismo, la cui storicizzazione è tutt’altro che definita, riguarda tutt’ora l’attività dello scrittore. Un punto rimane, comunque, imprescindibile: l’arte rimarrà sempre, la forma, che più di ogni altra attività dello spirito, esprime lo sgomento e lo stupore dinanzi al mistero della vita, e pone l’esigenza di opporre al negativo dell’esistenza la prospettiva di un mondo che non sia preda del non senso e del nulla.
Frank Kermode, sottolineando il bisogno dell’uomo di riportare l’ordine formale nel divenire caotico della vita, ritiene che sia attuale, pur nell’aggiustamento al mutato senso della realtà, il paradigma apocalittico, in cui la vita scorre dall’inizio, attraverso una fase intermedia, verso una fine che la riscatta dal caos. Il romanzo, considerato dallo studioso inglese, la principale forma letteraria della modernità, non può prescindere da un ordine formale, congeniale alle aspettative esistenziali dell’uomo, che sono percepite all’interno di un tempo che tende, nel suo divenire, ad una conclusione che lo giustifichi. Nell’adattarsi alla sensibilità moderna il senso della fine, scrive Kermode, da imminente diventa immanente, per cui il romanzo esprimerebbe la condizione di crisi dell’età moderna, rimanendo pur sempre dentro il modello apocalittico. Il nuovo, se vuole comunicare un che di significativo, deve mantenere un rapporto di congruenza tra finzione letteraria e tempo della vita: “Dunque la novità nell’arte è o comunicazione o chiasso. Se è chiasso c’è ben poco da dire. Se è comunicazione è inevitabilmente in relazione con qualcosa di più antico”.
Dal bisogno di trascendere l’irrazionale e il negativo dell’esistenza e di tutto l’ambito fenomenico, rimane escluso il periodo della fanciullezza, quale ci appare nella rievocazione del ricordo. In questa età, l’uomo non sperimenta la condizione di precarietà e di fragilità dell’esistere e vive in armonia con l’intero universo, di cui si sente il centro. Per questo la fanciullezza ci appare come un paradiso perduto e l’arte, esprimendo in immagini, l’insopprimibile desiderio dell’uomo di raggiungere la vita vera, non è altro che il tentativo di eternare l’antica condizione della pienezza del vivere sperimentata nella fanciullezza. Un ritorno, che non è una pura e semplice ripetizione del passato, in quanto la trasfigurazione estetica rimane segnata dall’esperienza della finitudine, che trapelerà sempre nella creazione delle forme. Qualsiasi forma d’arte è sempre un balenare della luce sull’orizzonte dell’Essere.
Paul Ricoeur, pur ritenendo il modello apocalittico di Kermode soggetto ad essere soppiantato da altri paradigmi e ipotizzando, persino, con Walter Benjamin l’evenienza della fine del romanzo, in quanto gli uomini non hanno più alcuna esperienza comune da condividere, scrive: “Forse, in effetti, noi siamo i testimoni – e gli artefici – di una certa morte, quella dell’arte del raccontare, dalla quale deriva quella della narrazione in tutte le sue forme. Forse lo stesso romanzo è sul punto di morire in quanto narrazione. Niente, infatti, ci permette di escludere che l’esperienza cumulativa che, almeno nell’area culturale dell’Occidente, ha prodotto uno stile storico riconoscibile sia oggi colpita a morte. […] Nondimeno bisogna, nonostante tutto, dar credito alla domanda di concordanza che struttura ancora oggi l’attesa dei lettori e credere che nuove forme narrative, che non sappiamo ancora nominare, sono già sul punto di nascere e che attesteranno come la funzione narrativa possa subire una metamorfosi ma non morire. E questo perchè non sappiamo che cosa sarebbe una cultura nella quale non si sappia più che cosa significhi raccontare.”.
Proust, Mann e Kafka, testimoni e cantori del tramonto della borghesia europea, si interrogarono sul ruolo e la responsabilità dell’artista, aprendo la strada alla crisi del romanzo moderno e al problematico dualismo arte-vita, di cui non si vede ancora il componimento. Leopardi, potrebbe sembrare estraneo a questa problematica; in effetti, a parte che anche lui fu critico delle belle sorti e progressive della borghesia del suo tempo, non bisogna dimenticare che la sua poesia nasce dal bisogno di superare il nichilismo, a cui, lo conduceva il suo pensiero filosofico e con cui l’artista, oggi che siamo nel bel mezzo di una crisi che investe tutti gli ambiti della vita, deve confrontarsi. Questo il problema che Leopardi, per primo, ha esplicitato: o scrivere perché l’arte apre lo spazio alla possibilità di un mondo altro dal nichilismo, o tacere. Un dilemma che, per non essere una questione puramente estetica, è metafisica. Gesualdo Bufalino, infine, non discostandosi dal nichilismo leopardiano, pur consapevole della futilità degli artifici della retorica, non può fare a meno di ricorrere ad essa, per esorcizzare con la bellezza della parola l’insignificanza della vita.
Solo che l’arte in Bufalino, come in Leopardi, in Proust, in Mann e in Kafka, resterà sempre un passo indietro rispetto alla vita, alla vita vera, di cui la fanciullezza è stata la poesia: questo il limite dell’arte e il destino dell’artista sarà sempre quello di tendere all’assoluto, ben consapevole della sua inattingibilità. Sotto questo aspetto, l’arte, quando non scade a vuoto compiacimento di sfogo sentimentale, o a sperimentalismi fine a sé stessi, affonda nel più antico desiderio dell’uomo di capire il senso del tempo della sua vita, di cui non cesserà di tessere il racconto. Se così è: “Come la filosofia e le scienze umane, – scrive Todorov – la letteratura è pensiero e conoscenza del mondo psichico e sociale in cui viviamo. La realtà che la letteratura vuole conoscere è semplicemente (ma, al tempo stesso, non è nulla di più complesso) l’esperienza umana”.
Armando Faraone
___________
Ringrazio l’amico Editore Lombardi per aver consentito alla pubblicazione. Biagio Iacono














